 Ci siamo già occupati, nel precedente saggio Patriota o traditore? Il processo a Knut Hamsun, della cornice generale in cui ebbe luogo il processo al grande scrittore norvegese, accusato di collaborazionismo al termine della seconda guerra mondiale. In quella sede abbiamo tracciato il quadro storico entro cui collocare l’intera vicenda, con tutti i suoi risvolti politici, culturali, umani; e, al tempo stesso, abbiamo cercato di presentarla come una vicenda esemplare, paradigmatica di tutta una generazione di intellettuali – e non solo di intellettuali – che, fra il 1939 e il 1945, fecero la scelta sbagliata – la scelta che li avrebbe condotti, a guerra finita, davanti ai tribunali dei vincitori, fossero le democrazie occidentali, l’Unione Sovietica di Stalin, la Jugoslavia di Tito o i piccoli Paesi d’Europa che avevano subito l’occupazione nazista. Si tratta di nomi eccellenti, da Ezra Pound a Céline, da Ungaretti a Drieu la Rochelle, da Gentile a Heidegger, da Carl Schmitt al generale Krasnov, autore di fortunatissimi romanzi storici negli anni Venti e Trenta.
Ci siamo già occupati, nel precedente saggio Patriota o traditore? Il processo a Knut Hamsun, della cornice generale in cui ebbe luogo il processo al grande scrittore norvegese, accusato di collaborazionismo al termine della seconda guerra mondiale. In quella sede abbiamo tracciato il quadro storico entro cui collocare l’intera vicenda, con tutti i suoi risvolti politici, culturali, umani; e, al tempo stesso, abbiamo cercato di presentarla come una vicenda esemplare, paradigmatica di tutta una generazione di intellettuali – e non solo di intellettuali – che, fra il 1939 e il 1945, fecero la scelta sbagliata – la scelta che li avrebbe condotti, a guerra finita, davanti ai tribunali dei vincitori, fossero le democrazie occidentali, l’Unione Sovietica di Stalin, la Jugoslavia di Tito o i piccoli Paesi d’Europa che avevano subito l’occupazione nazista. Si tratta di nomi eccellenti, da Ezra Pound a Céline, da Ungaretti a Drieu la Rochelle, da Gentile a Heidegger, da Carl Schmitt al generale Krasnov, autore di fortunatissimi romanzi storici negli anni Venti e Trenta.
Ora, pertanto, dando per acquisite le precise circostanze storiche in cui si svolse il processo, vogliamo riportare la testimonianza diretta del vecchio scrittore norvegese, quasi novantenne, pressoché sordo e vicino alla cecità, così come si può leggere nel suo bellissimo libro Io, traditore (titolo originale: Paa Gjengrodde stier, ossia Per i sentieri dove cresce l’erba, o anche Per i sentieri rinselvatichiti; traduzione italiana di Alfhild Motzfeldt, Roma, Ciarrapico editore, s. d. [ma 1962], pp. 225-237).
Ricordiamo soltanto che Hamsun, accusato di alto tradimento per aver appoggiato il governo filotedesco di Vidkun Quisling, dal 1945 al 1948 era stato rinchiuso forzatamente in casa di cura (tipico esempio dell’uso politico della psichiatria non solo nei regimi totalitari, come l’URSS, ma anche in quelli liberal-democratici); e che aveva rifiutato con sdegno di essere dichiarato infermo di mente. Al termine del processo, nel corso del quale si era comportato con estrema dignità e non aveva abiurato le sue idee, era stato condannato e privato dei suoi beni, a nome del popolo norvegese.
Nato nel 1859 nell’estremo nord della Norvegia, e vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1920, egli aveva ottantanove anni all’epoca del processo; sarebbe vissuto ancora quattro anni, spegnendosi a Nörholm il 19 febbraio 1952.
“Spuntò il gran giorno. Il tribunale sedette.
“Venni ammesso in una buia sala d’udienza. E poiché nell’ultimo anno la mia vista s’era indebolita, senza contare ch’ero sordo, dovettero condurmi per mano. Ero stordito e appena distinguevo un oggetto dall’altro. Prima prese la parola il presidente, quindi parlò il mio difensore d’ufficio e quindi seguì una pausa.
“E io non avevo né udito, né veduto tutto ciò ch’era passato. Tuttavia mi tenni calmo. Intanto cominciai a vedere un po’ meglio tutte le cose e le persone che mi stavano attorno.
“Dopo la pausa, mi venne data la parola per esporre i fatti. Era un po’ difficile per me poter leggere con quella cattiva luce, e pertanto mi venne dato un lume. Non vedevo molto meglio, con esso, per leggere alcuni appunti che tenevo nelle mani, e allora non insistetti nel cercar di capire ciò che vi avevo scritto. Ma forse non aveva alcuna importanza. Ciò che dissi sii trova riprodotto qui di seguiti in base al resoconto stenografico. (…)
 “«Non intendo parlare a lungo davanti a questo onorevole tribunale.
“«Non intendo parlare a lungo davanti a questo onorevole tribunale.
“«Non sono certo stato io ad aver annunziato alla stampa, molto, molto tempo fa, che oggi si sarebbe squadernato sotto i vostri occhi tutto il registro delle mie malefatte. Dev’essere stato qualcuno della cancelleria del tribunale, o qualcuno della pubblica accusa in combutta con qualche giornalista. Ciò, del resto, è molto coerente nella mia vicenda. Due anni or sono, in una lettera al Procuratore generale, io scrissi che intendevo rendere conto di tutto ciò che riguardava me, i miei e le mie cose, e quindi, ora che mi si presenta l’occasione, intendo concorrere all’enumerazione dei miei peccati, anche di quelli puramente spirituali.
“«Negli anni passati, ho ben veduto che lor signori del tribunale si son destreggiati nei miei confronti con molto zelo e bravura: cancellieri, avvocati e procuratori vi si sono applicati a gara. Tuttavia la sentenza della sezione istruttoria non risulta notevolmente influenzata da codeste singolari capacità. In generale si son seguite le direttive di sua eccellenza il Procuratore generale. Il quale, evidentemente, perseguiva un suo concetto mistico ch’io non intesi e non intendo neanche adesso; sì che debbo rinunziare ad intenderlo.
“«Del resto debbo pregare le signorie vostre di volermi scusare della mia, diciamo così, afasia, che serve ad evitare che parole ed espressioni che per caso mi venissero alle labbra, vadano al di là delle mie intenzioni.
“«D’altronde, da quel che ho potuto capire, debbo aver abbondantemente risposto a tutte le questioni postemi. Nei primi tempi, di quando in quando, veniva da Grimstad un agente di polizia e mi mostrava delle carte ch’io non mi davo la pena di leggere. Dopo di che si venne all’istruttoria, il che accadde… due, tre, cinque anni fa. Dato il gran tempo trascorso, non m’è possibile rammentarmi di nulla; tutto ciò che posso dire è che risposi sempre e ad ogni domanda.
“«Non mi comportai egualmente in quel lungo periodo di clausura nell’istituto psichiatrico di Oslo, dove si trattò di vedere se per caso io fossi pazzo; o, per dir meglio, si trattò di constatare che decisamente ero pazzo. In quel periodo mi furono rivolte delle domande così idiote, che non mi si può chieder conto di ciò che dissi o non dissi al professore interrogante.
“«Ciò che mi dovrebbe abbattere, e addirittura sino a terra, consiste unicamente negli articoli da me scritti nei giornali. All’infuori di ciò non esiste altra cosa che mi possa essere imputata. Ma quanto a ciò la mia contabilità è semplice e chiara, perché tutti i miei articoli si trovano sotto i vostri occhi, e quanto al resto non mi si può dire né ch’io abbia denunziato qualcuno, né che abbia partecipato a raduni, né che abbia fatto affari di borsa nera. Non ho militato in nessun partito, di nessun colore, e neppure in quello nazionalsocialista di cui si pretende che io sia stato membro. E come potrei essere stato membro del nazionalsocialismo, se per quanto io abbia cercato di capire che cosa mai fosse io non ci sono mai riuscito? Potrebbe darsi, tuttavia, ch’io abbia scritto qualche cosa nello spirito del nazionalsocialismo; questo non potrei assicurarlo con certezza perché non ho mai saputo quale fosse tale spirito. Se veramente l’avessi fatto, vorrebbe dire che quello spirito fu assorbito da me attraverso la lettura dei giornali. Comunque, come ho già detto, gli articoli sono sotto gli occhi delle signorie vostre ed io non intendo ridurne il numero né attenuarne l’importanza. Può essere che non siano del tutto ortodossi, quegli articoli, ma io intendo risponderne in pieno, adesso come prima e come sempre.
“«Prego tuttavia di voler tener conto che andavo scrivendo in un paese occupato, in un paese invaso e, a tal proposito, vorrei dare alcune brevi informazioni su me stesso.
“«Mi era stato detto che la Norvegia avrebbe occupato un posto eminente nella grande società mondiale germanica in gestazione; chi più, chi meno, allora tutti vi credevano. E anch’io vi avevo creduto. Quindi è chiaro che, scrivendo, dicevo ciò che credevo. E se dicevo che la Norvegia avrebbe occupato un posto assai eminente fra i paesi germanici d’Europa, e se parlavo in modo adeguato alla mia credenza, del paese occupante, ciò doveva, e ancora dovrebbe, essere inteso in modo onesto e sincero. Pertanto non avrei dovuto rischiare di cadere io stesso in sospetto, …e invece, per quanto paradossale potesse essere, vi caddi in pieno. Inoltre si sarebbe dovuto considerare ch’io mi trovavo, in permanenza, letteralmente circondato da ufficiali tedeschi, e nella mia stessa casa, e persino durante la notte. Spesse volte sino all’albeggiar del mattino. Talvolta avevo l’impressione d’essere circondato da osservatori; ossia da persone deputate a sorvegliar me e la mia casa. Quei tedeschi, che d’altronde erano d’ una classe relativamente elevata, per ben due volte (se ben rammento) mi dissero chiaramente ch’io non mi comportavo come alcuni svedesi (e me ne fecero il nome) che pure erano d’un paese neutrale, mentre invece la Norvegia non lo era.
“«No, non si era davvero contenti di me. Ben altro si sarebbero aspettati da me, assai più ch’io non avessi dato. E quando io, in siffatte circostanze, mi mettevo a scrivere, dovrebbe comprendersi che io dovevo tenermi, per così dire, in equilibrio fra gl’interessi del paese e l’altra parte. E questo non dico certo per scusarmi, per difendermi, ma soltanto come una spiegazione a questo onorevole tribunale.
“«Nessuno in tutto il paese mi diceva che fosse male ciò che andavo scrivendo. Ero relegato nella mia stanza, tutto solo con me stesso, e non sentivo nulla. Ero tanto solo che nessuno avrebbe potuto aver commercio spirituale con me; si doveva persino picchiare sulla canna fumaria della stufa per farmi discendere a prendere i miei pasti. Quel rumore lo potevo sentire. Una volta mangiato, me ne risalivo nella mia stanza e lì restavo. Per mesi e per anni in simile maniera. Né alcuno mi fece mai il più piccolo rilievo circa la mia maniera di comportarmi: non me ne ero fuggito e pensavo di aver amici nei due campi norvegesi in lotta. Sì, fra i cosiddetti quislinghi ed i jossinghi. Ma non mi pervenne mai il più piccolo cenno di dissenso, il più piccolo suggerimento di cambiar rotta, dal mondo esterno. No, il mondo esterno si teneva diligentemente e prudentemente da parte. E accadeva raramente, o mai, che dalla mia casa o dalla mia famiglia potessi avere qualche notizia o qualche aiuto. Tutto lo si doveva far in iscritto, il che era una faccenda assai fastidiosa. In siffatte condizioni di cose, non poteva attenermi che a due soli giornali: l’Aften Post e il Fritt Volk; gli unici che mi pervenissero. E in essi non si diceva affatto che ciò che io scrivevo fosse male. Tutt’altro!
“«Ciò ch’io scrivevo non era sbagliato nella sua essenza, e nemmeno era sbagliato nel momento che lo scrivevo. Era giusto ciò che scrivevo e quando lo scrivevo.
“«Cercherò di spiegarmi meglio. Perché scrivevo? Scrivevo per impedire che la Norvegia, ossia i giovani e gli uomini adulti, si comportassero stoltamente verso la potenza occupante, che la provocassero inutilmente col solo risultato di portar se stessi alla perdizione e alla morte. Questo era ciò che scrivevo, questo era il tema che svolgevo in vari modi.
“«E quanto a coloro che oggi trionfano essendo usciti dalla mischia apparentemente vittoriosi, essi non hanno certo ricevuto, come me, la visita d’intere famiglie, e di bambini, e di uomini fatti, e di vecchi che venivano a raccomandarmi o i loro padri, o i loro figli, o i loro fratelli rinchiusi nei campi di concentramento dietro una siepe di ferro spinato e condannati a morte. Sì, signori del tribunale, erano condannati a morte. Io non possedevo certo alcun potere, tuttavia era da me che venivano. No, non possedevo alcun potere, ma potevo scrivere, potevo telegrafare, però. E allora scrivevo e telegrafavo. Scrivevo a Hitler e a Terboven. Né sdegnai di seguir vie traverse. Mi rivolsi infatti persino a un tale, il cui nome credo che fosse Müller, che aveva fama di saper influire sul potere costituito. Ho motivo di credere che debba esistere in qualche luogo una specie di archivio dove si trovan raccolte tutte quelle lettere e i telegrammi. E furono veramente tanti!
“«Tutto il giorno telegrafavo e, in caso d’urgenza, telegrafavo anche la notte. Si trattava della vita e della morte per i miei compatrioti. Mi riuscì d’ottenere che la moglie del mio fattore trasmettesse, per telefono, all’ufficio postale i miei telegrammi, visto che, a cagion dell’udito, io non avrei potuto farlo. Ma furon per l’appunto codesti telegrammi a render sospettosi i tedeschi nei miei riguardi, mi consideravano una specie di mediatore; un mediatore piuttosto infido, un mediatore che doveva esser tenuto d’occhio. E andò a finire che lo stesso Hitler rigettava le mie istanze. Mi si spiegò che ne era affatto stufo e mi si rimandò a Terboven. Ma Terboven non si dette la pena di rispondermi nemmeno una volta. Sino a che punto i miei telegrammi fossero di qualche aiuto non lo so; come pure non so fino a che punto impressionassero i miei concittadini gli articoletti che inviavo ai giornali. Penso però che in luogo di svolgere la mia attività, forse del tutto vana, inviando lettere, articoli e telegrammi, avrei meglio provveduto ai casi miei mettendo al riparo la mia stessa persona. Avrei ben potuto fuggirmene in Svezia, come si fece da tanti altri. Non mi sarei certo smarrito, colà: vi avevo molti amici, vi si trovavano i miei grandi e potenti editori. Senza poi contare che avrei anche potuto trovare il verso di sgattaiolarmela in Inghilterra, come si faceva da molti altri. I quali si son poi visti tornare, in aria d’eroi, pel fatto che avevano abbandonato il loro paese, pel fatto che se ne erano scappati. Io non feci nulla di tutto ciò; io non mi mossi. Una simile fuga non mi sarebbe mai venuta in mente. Credetti di poter servire assai meglio il mio paese restando dov’ero. Avrei, per esempio, potuto occuparmi della mia terra nei limiti delle mie capacità. Eran tempi di penuria e la nazione mancava di tutto. Avrei inoltre potuto impiegare la mia penna per quella Norvegia che doveva avere un posto tanto eminente fra i paesi germanici europei. Codesto pensiero, nei primi tempi, mi aveva affascinato, mi aveva entusiasmato, mi possedeva del tutto. Non saprei dire se, in tutto quel tempo del mio sequestro in casa, codesto pensiero mi avesse abbandonato; comunque mi pareva un pensiero grande per la mia Norvegia; e, a dir vero, anche oggi mi pare tale. E mi pareva che, per quell’idea, valesse la pena di faticare, di lottare. Pensate: la Norvegia del tutto indipendente, rilucente di luce propria nell’estremo nord dell’Europa! E quanto al popolo tedesco, come pure al popolo russo, io li vedevo come astri rilucenti. Codeste due potenti nazioni mi possedevano, e pensavo che esse non avrebbero deluso le mie speranze!
“«Sennonché, ciò che feci non mi andò bene; proprio non mi andò bene. Presto mi trovai del tutto disorientato; e il momento del mio maggior disorientamento fu quando il re, con tutto il governo, di loro spontanea iniziativa, abbandonarono il paese. In quel modo misero se stessi fuori causa. Quando ebbi notizia di un tal fatto, mi parve che la terra mi si aprisse sotto i piedi. Mi trovavo come sospeso tra cielo e terra; non vedevo nulla di saldo su cui appoggiarmi, e me rimasi lì a scrivere, a telegrafare, a meditare. Il mio stato spirituale, in quel tempo, non fu che meditazione. E su tutto meditavo. Così facendo potevo ricordare a me stesso che l’orgogliosa rinomanza, già posseduta dalla Norvegia, aveva attraversato tutta la Germania germanica, diventando grande in tutto il mondo. E non credo affatto di aver avuto torto a pensar queste cose; ma fu ritenuto un errore. Sì, anche questo fu ritenuto un errore. Eppure era una verità palmare nella nostra nuova storia. Tuttavia la mia azione non raggiunse la meta che s’era prefissa, anzi, fu dato a credere al cuore di tutti che io me ne stessi lì a tradir la Norvegia, quella stessa Norvegia che, viceversa, mi studiavo d’innalzare. Sì, ch’io stessi a tradirla. Ebbene, la vada pure così; ricada pure su di me tutto ciò che il cuore di tutto il mondo mi vuole imputare. È questa la mia perdita, e debbo subirla. Tanto, fra cento anni, tutto sarà dimenticato. Fra cento anni anche quest’onorevole tribunale sarà caduto nel nulla. Tutti i nomi di tutte le persone qui presenti saranno cassati dalla terra, fra cento anni! Nessuno sarà più ricordato, nessuno sarà più nominato, fra cento anni! E tutto il nostro destino sarà cancellato dalla terra!
“«Quando passavo i miei giorni a scrivere, facendo del mio meglio per salvar dalla morte i miei concittadini, non facevo dunque nient’altro che tradire il mio paese? Già, questo è quel che si dice. Si dice ch’ero un traditore della patria. Va bene. Vada pure così. Ma io non la sentivo così, non la concepivo così. E non la sento e non la concepisco così nemmeno adesso. Nell’anima mia regna la pace; la mia coscienza è tranquilla.
“«Tengo in alta considerazione il parere della generalità; anche più in alto tengo il rispetto per l’autorità giudiziaria del mio paese: ma non più in alto della mia coscienza del bene e del male, di ciò ch’è giusto e di ciò ch’è ingiusto. Credo d’essere abbastanza vecchio per aver diritto di possedere una linea di condotta. Questa è la mia.
“«Nella mia ormai troppo lunga vita, in tutti i paesi dove ho viaggiato, fra tutte le razze con cui mi son mescolato, ho sempre ed eternamente portato nel cuore il mio paese natale e l’ho affermato. La mia patria intendo conservarla là dove si trova e nell’anima mia. E non mi resta che attendere la vostra definitiva sentenza.
“«Dopo di che, tengo a ringraziare quest’onorevole tribunale per avermi pazientemente ascoltato.
“«Non eran che queste poche e semplici cose che desideravo rappresentare a questo onorevole tribunale, in sede di dichiarazione, affinché non sembri, nel corso del dibattimento, ch’io sembri altrettanto muto quanto sordo. Non ho minimamente voluto pronunziare un’arringa in mia difesa; se, viceversa, il mio discorso può esser apparso tale, ciò è dipeso dal fatto che ho dovuto rappresentare alcune circostanze da tutti ignorate. No, non ho inteso far la mia difesa, tanto è vero che avrei potuto convalidare il mio assunto mediante le deposizioni di alcuni testimoni e me ne sono astenuto. E nemmeno ho accennato a tutta la documentazione che potrei mettere a disposizione dell’onorevole tribunale.
“«Tutto ciò può aspettare; può essere rinviato ad altra volta, forse a una migliore occasione, forse a un altro tribunale. Il suo giorno verrà. E potrebb’essere anche domani. Io posso attendere: ho tanto tempo davanti a me. Che sia morto o che sia vivo, questo non può avere alcuna importanza. È assolutamente indifferente per l’intero mondo come vada a finire un singolo individuo. Il quale, in questo caso sono io. Ed io, come ho detto, posso aspettare. Troverò bene qualche cosa da fare.
“Dopo il mio discorso, fu la volta del pubblico ministero. Dopo di lui toccò al mio difensore d’ufficio. E intanto io, ancora per ore e ore, dovetti starmene là senza affatto capire ciò che andava accadendo. Alla fine l’onorevole tribunale mi pose delle domande scritte a cui risposi verbalmente.
“E così se ne passò quella memoranda giornata; poi fu sera e venne il buio. Era finita.”
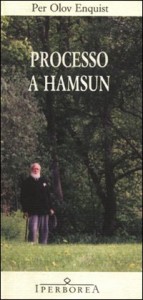 Abbiamo sostenuto, nel nostro precedente articolo, di non voler cadere nell’atteggiamento dello scrittore svedese Per Olov Enquist (nato nel 1934), nel suo libro Processo a Hamsun (traduzione italiana Milano, Iperborea, 1996), il quale finisce per impancarsi a giudice di un autoproclamato tribunale della cultura e per trattare Hamsun – artista tanto più grande di lui – come l’imputato di un secondo e definitivo processo, quello ideale. Peggio, Enquist ha finito per indossare i panni dello psichiatra (proprio il tipo di giudice che Hamsun aveva sdegnosamente rifiutato), sentenziando che il peccato capitale del grande scrittore era stato l’orgoglio e che, per aver voluto guardare troppo lontano, egli non aveva voluto abbassare lo sguardo sulla realtà più vicina e immediata. Secondo lo scrittore svedese, Hamsun non vide – o, per dir meglio, non volle vedere – le camere a gas e tutto il resto, perché aveva lo sguardo puntato troppo in alto. Una sorta di presbiopia ideologica e spirituale, insomma. Peccato che una tale sentenza, o meglio, che una tale diagnosi clinica, pecchi terribilmente di anacronismo, in quanto si riduce a un misero senno del poi.
Abbiamo sostenuto, nel nostro precedente articolo, di non voler cadere nell’atteggiamento dello scrittore svedese Per Olov Enquist (nato nel 1934), nel suo libro Processo a Hamsun (traduzione italiana Milano, Iperborea, 1996), il quale finisce per impancarsi a giudice di un autoproclamato tribunale della cultura e per trattare Hamsun – artista tanto più grande di lui – come l’imputato di un secondo e definitivo processo, quello ideale. Peggio, Enquist ha finito per indossare i panni dello psichiatra (proprio il tipo di giudice che Hamsun aveva sdegnosamente rifiutato), sentenziando che il peccato capitale del grande scrittore era stato l’orgoglio e che, per aver voluto guardare troppo lontano, egli non aveva voluto abbassare lo sguardo sulla realtà più vicina e immediata. Secondo lo scrittore svedese, Hamsun non vide – o, per dir meglio, non volle vedere – le camere a gas e tutto il resto, perché aveva lo sguardo puntato troppo in alto. Una sorta di presbiopia ideologica e spirituale, insomma. Peccato che una tale sentenza, o meglio, che una tale diagnosi clinica, pecchi terribilmente di anacronismo, in quanto si riduce a un misero senno del poi.
Quanti Norvegesi, quanti Europei, nel 1939-45, non videro o non vollero vedere le fosse di Katyn, ove i carnefici di Stalin gettarono migliaia e migliaia di ufficiali polacchi, fucilati dopo l’invasione russo-tedesca del 1939 e dopo la resa dell’esercito polacco; come non vollero vedere lo sterminio dei kulaki, i gulag della Siberia e dell’Estremo Oriente, l’assassinio di Trotzkij nel Messico neutrale? Quanti Inglesi non vollero vedere le bombe incendiarie che distrussero Dresda, quanti Americani non vollero vedere le atomiche di Hiroshima e Nagasaki; o, peggio, le giustificarono a cuor leggero, credendo alla storiella della necessità militare “per risparmiare vite umane”? Quanti Iugoslavi non vollero sapere delle stragi in massa dei cetnici e degli ustascia; quanti Italiani non vollero nemmeno sentir parlare delle foibe e del dramma dei profughi giuliani? C’è bisogno di ricordare che questi ultimi, costretti a fuggire, da un giorno all’altro, da Pola, da Fiume, da Zara, senza nulla poter portare con sé, furono accolti con indifferenza o con fastidio dai loro compatrioti, presso i quali avevano cercato accoglienza; e che si videro lungamente relegati nei campi profughi, come dei lebbrosi? Che alcuni oratori del Partito Comunista Italiano, nel corso di pubblici comizi, li paragonarono – con irridente gioco di parole – ai membri della banda del delinquente Giuliano, che in quegli anni insanguinava le contrade della Sicilia?
Da parte nostra, non cercheremo né di accusare Knut Hamsun, né di difenderlo; piuttosto di capirlo, sine ira et studio, e di trarre una morale alla sua emblematica vicenda.
 Ci pare che nemmeno Anton Reininger, nella sua Introduzione alla edizione italiana del capolavoro di Hamsun, Pan ( Milano, Mondadori, 1981, pp. 11-12), sia riuscito a sottrarsi alla logica del giudice, là dove ha scritto:
Ci pare che nemmeno Anton Reininger, nella sua Introduzione alla edizione italiana del capolavoro di Hamsun, Pan ( Milano, Mondadori, 1981, pp. 11-12), sia riuscito a sottrarsi alla logica del giudice, là dove ha scritto:
“Quasi novantenne scrive il suo ultimo libro, Per i sentieri dove cresce l’erba, la commovente testimonianza di una vecchiaia umiliata dalla storia. Ma anche adesso, parimenti ai suoi eroi, Hamsun rifiuta di assumersi la propria responsabilità. Chi si sa al servizio della vita non può riconoscere le categorie politiche e storiche, sentite quali sovrastrutture di importanza secondaria.
“Combattendo le proprie inclinazioni anarchiche e desiderando superare le proprie lacerazioni di intellettuale fluttuante fra le classi sociali, ma in ogni caso antiborghese, Hamsun si era infine rifugiato nelle semplificazioni di una Weltanschauung che con gli anni si allontanava sempre di più dalla realtà sociale e ai suoi sviluppi effettivi, per sostituirle la fantasmagoria di un’utopia regressiva”.
Ma come si può dire, onestamente, che Hamsun rifiutò la propria responsabilità? È vero piuttosto il contrario. Non cercò scusanti; non chiamò testimoni a discarico (anche se avrebbe potuto); non volle neanche nominare un avvocato difensore, tanto che gli venne assegnato un avvocato d’ufficio. Disse che non pensava di aver agito da traditore verso il proprio Paese e che, se si fosse trovato nuovamente nella stessa situazione, avrebbe agito nello stesso modo. Dunque si assunse la sua responsabilità, tutta intera. Oppure l’espressione “Hamsun rifiuta di assumersi la propria responsabilità” significa che egli rifiutò di riconoscere che aveva avuto torto, che si era completamente sbagliato? Forse sbagliò a rimanere in Norvegia sotto l’occupazione tedesca; forse sbagliò a non fuggire nella vicina Svezia neutrale o, addirittura, in Gran Bretagna, come avevano fatto il re e il governo (ma anche questo è dubbio; e noi Italiani ne sappiamo qualche cosa, di simili fughe delle teste coronate, mentre il Paese viene invaso e l’esercito abbandonato a se stesso). Forse sbagliò a credere in Quisling e in Hitler; a illudersi che la sua Patria, nel nuovo ordine europeo instaurato dal nazismo, avrebbe ottenuto di svolgere “un ruolo eminente”. A lui, che odiava la Gran Bretagna e che odiava lo spirito borghese, pareva che solo dalla Germania sarebbe venuta alla Norvegia una indipendenza vera, degna del suo grande passato; una indipendenza fiera, per gli eredi dei Vichinghi; non una semi-indipendenza, in un mondo materialista e venale, dominato dalle plutocrazie di Londra e Washington.
Il fatto è che furono in molti a sbagliare, in quegli anni oscuri; anche fra coloro che, nel 1945, si vennero a trovare dalla parte “giusta”, ossia da quella dei vincitori. Hamsun rivendicò, con orgoglio, di essersi appellato al tribunale della propria coscienza, e di ritenerlo superiore sia alla patria, sia alla corte che lo stava giudicando.
Decine di Norvegesi, durante e dopo il processo, si recarono alla casa di Hamsun e gli gettarono in giardino le copie dei suoi libri, come supremo gesto di ripulsa. Non sappiamo se andarono a trovarlo anche i parenti delle persone arrestate dai Tedeschi al tempo dell’occupazione e che lo avevano scongiurato di adoperarsi per la salvezza dei loro cari; cosa che egli sempre aveva fatto.
Ma così va il mondo. Quando cade un regime sgradito, ciascuno vorrebbe lavarsi la coscienza proiettando ogni male, ogni responsabilità sull’altro, in modo da far maggiormente risaltare la propria limpidezza morale. È un gioco vecchio come il mondo: il vae victis!, «guai ai vinti!», degli antichi Romani. I vinti devono sopportare anche il peso del disprezzo che i vincitori nutrono inconsciamente per una parte di sé stessi: perché in una guerra non vi sono innocenti, e meno che mai in una guerra civile. Come scrisse Cesare Pavese, il sangue del fratello ucciso pone sempre una domanda ineludibile, una muta domanda che attende un perché. Prova ne sia che, fino a pochissimi anni fa (e, in certi ambienti, ancora oggi), era assolutamente proibito definire gli eventi italiani del 1943-1945 come una guerra civile. No, si diceva, era stata una guerra di liberazione contro lo straniero occupante e contro pochi suoi prezzolati vassalli; una guerra in cui la stragrande maggioranza del popolo italiano aveva scelto nettamente da che parte stare: da quella della libertà e della giustizia. Ora, finalmente, si ammette – senza con questo rimuovere le nobili motivazioni di quanti combatterono realmente per ragioni ideali – che fu proprio una guerra civile, una guerra di Italiani contro altri Italiani, di fratelli contro fratelli. Ed è ancora oggi difficile parlare di alcune pagine oscure di essa – le stragi di fascisti o presunti fascisti dopo il 25 aprile del 1945; la tragedia degli infoibati della Venezia Giulia -, perché ancora oggi, a oltre sessant’anni di distanza, c’è qualcuno che vorrebbe seppellirle nell’oblio. E c’è ancora chi vorrebbe mettere tutti coloro che combatterono dalla parte che, poi, è stata perdente, in un unico fascio di riprovazione morale, come se fossero stati, tutti indistintamente, dei criminali e dei miserabili. E per convincersi che non è stato così, basta leggere le lettere di alcuni condannati a morte dai plotoni d’esecuzione partigiani, dopo la fine delle ostilità. Vi sono, ad esempio, alcune lettere di ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana, ragazze giovanissime che furono uccise (contro le leggi di guerra) solo per la divisa che indossavano, che rivelano un alto sentire etico e un vivissimo amor di Patria. Alcune sono contenute nei libri di Gianpaolo Pansa che, a loro volta, sono stati accolti da un coro di insulti e di critiche, non tutte in buona fede, per il semplice fatto che alcuni vorrebbero che la memoria funzioni a senso unico: che preservi, cioè, solo il ricordo di alcune cose, ma non di altre.
Allo stesso modo, solo da pochi anni a questa parte si comincia a parlare apertamente, e a fare delle serie ricerche storiche, intorno ai bombardamenti anglo-americani che sconvolsero le città italiane (per non parlare di quelle tedesche!) durante la seconda guerra mondiale. Prima, non si poteva. Gli Anglo-Americani erano i buoni, i liberatori: quelli che gettavano pane e sigarette dall’alto dei loro carri armati, mano a mano che avanzavano lungo le strade della Penisola. Sarebbe stata una bella ingratitudine, quella di permettersi di criticarli. Perciò si è taciuto, troppo a lungo, anche davanti all’evidenza: e cioè che quei bombardamenti furono diretti, intenzionalmente, non contro l’industria di guerra o contro il sistema dei trasporti, ma principalmente contro la popolazione civile, allo scopo di terrorizzarla e demoralizzarla il più possibile, per spingerla a chiedere la resa e risparmiare agli Alleati preziose vite umane. E allora tanto peggio per quelle città, piene zeppe di vecchi, donne e bambini; di profughi dalle zone invase o minacciate; di sfollati, senza più beni e mezzi di sostentamento. E chi parla più di Zara, rasa al suolo dall’aviazione anglo-americana fin dal 1943, per nessun’altra ragione strategica se non quella di prepararne la cessione alla Jugoslavia comunista del maresciallo Tito?
Ma torniamo ad Hamsun. Egli non era un politico, perciò sarebbe sbagliato collocare il suo dramma finale su di un piano squisitamente politico. È probabile che di politica ci capisse poco o niente. Era un poeta che amava la terra, la natura, l’anima delle cose; e, fra gli tutti i generi di coloro che siamo soliti riunire nella generica categoria degli intellettuali, il poeta è quello che meno di tutti può essere accusato d’incomprensione della politica. Sì, è vero: lo sguardo di un poeta – di qualsiasi vero poeta – è rivolto verso l’alto; e, per questo, può succedere che egli non sappia vedere bene le cose che gli stanno più vicino – non dal punto di vista pratico e immediato, quantomeno. È giusto incolparlo di ciò?
Ma, si dirà, anche il poeta è un uomo; e, come uomo, anche il poeta deve rispondere delle sue scelte, dei suoi atti. Dei suoi atti, come si è visto, Hamsun non ebbe motivo di vergognarsi; e non ci fu nessuno che poté incolparlo di qualcosa. Delle sue scelte, forse sbagliate, si assunse la piena ed intera responsabilità. Cercò di fare il bene del proprio Paese, in un’Europa ove i piccoli Stati dovevano fare buon viso al gioco spietato delle grandi potenze. Si ricordi quel che accadde alla Finlandia, che avrebbe chiesto solo di rimanersene in pace e in disparte, ma venne ugualmente attaccata ed invasa, nel 1939, dall’Unione Sovietica di Stalin. E che poi, per cercar di riprendersi le province perdute e per tutelare la propria indipendenza, si schierò con la Wehrmacht all’epoca dell’Operazione Barbarossa, nel 1941. Erano dunque dei nazisti, i Finlandesi? Niente affatto; erano semplicemente dei patrioti, costretti a lottare contro la prepotenza degli stati più forti.
Nessuno, poi, ricorda l’invasione dell’Islanda da parte dei Britannici; anzi, si vorrebbe adoperare un termine diverso da quello di “invasione”: si trattava di prevenire uno sbarco dei Tedeschi che, a loro volta, avevano invaso la Danimarca nel 1940. I Britannici, si sa, sono i “buoni”; quando invadono un Paese, lo fanno sempre per il suo bene e non nel loro interesse. Basti pensare al simpatico termine di “Alleati” che essi e gli Americani si sono attribuiti, e con il quale gli storici di tutto il mondo continuano a indicarli, parlando della seconda guerra mondiale. Già, “Alleati”: ma alleati di chi, e perché? Alleati fra di loro? Ma allora perché non designare con il termine di “Alleati”, così amichevole e rassicurante, anche gli Italo-Tedeschi, che combatterono fianco a fianco, dall’Africa alla Russia, fra il 1940 e il 1943? Oppure gli Anglo-Americani sono denominati “Alleati” per il fatto che erano alleati del mondo libero, contro le forze del male rappresentate dal Tripartito? Se è così, bisognerebbe spiegare cosa ci faceva uno come Stalin al loro fianco, nel ruolo, appunto, di alleato numero uno; a meno che si voglia sostenere che Stalin era un campione del mondo libero.
Questo, e non altro, è il contesto in cui Knut Hamsun, come i suoi connazionali, si trovò a dover fare delle scelte. Il mondo della politica così com’era (e com’è), e non come qualcuno vorrebbe che fosse stato (o che fosse), per dirla con Machiavelli. Egli, perciò, decise di scegliere quello che, allora, gli parve il male minore. Non il bene: il male minore. Nessuna guerra porta il bene, in nessuna guerra trionfa il bene; ogni guerra è il male, per definizione. C’è soltanto il presidente americano Bush che si ostina ad affermare, ancor oggi, che le guerre portano libertà, democrazia e progresso Ma è molto probabile che lui sia il primo a non crederci affatto. Gli esseri umani vivono nel mondo del possibile; e il raggio di ciò che è possibile è determinato dalla misura della loro imperfezione. È giusto che essi aspirino alla giustizia e alla felicità; ma al mondo ci saranno sempre i poveri, ci saranno sempre le ingiustizie: perché la natura umana è quella che è, ossia imperfetta. Anche per questo, i poeti sono preziosi e necessari. Perché, al di là e al di sopra delle miserie umane, sanno rivolgere lo sguardo sempre in alto.
Perfino durante il suo lungo internamento, Knut Hamsun continuava a guardare con amore la natura fuori dalla sua finestra; e si commuoveva alla semplice bellezza di un pioppo e di un abete nano, che crescevano nel giardino sottostante. Sì: hanno lo sguardo rivolto in alto, i poeti. Dobbiamo esser loro grati perché, con quello sguardo, essi colgono una scintilla di luce divina anche per noi, che restiamo immersi nelle dense tenebre del contingente e del relativo; e ci spalancano davanti, come un dono ineffabile, uno squarcio fuggevole dell’assoluto e dell’eterno.
:: Novopress.info Italia » Blog Archive » «Io, traditore»: il testamento spirituale di Knut Hamsun
[…] Continua la lettura […]