Prima di passare a trattar partitamente dell’«Arte Regia», è opportuno fissare nei termini più netti il suo carattere di realtà.
Sarebbe assai lontano dal comprendere l’essenza di quest’Arte colui che, sulla base dell’analogia con espressioni mistiche e religiose, quali «morte e resurrezione», «rinascita», «mortificazione», ecc., venisse all’idea, che il tutto si riduca a qualcosa di «morale», di vagamente spiritualistico e, appunto, di «mistico». È ad un simile piano, difatti, che quasi tutti sono subito portati a pensare da termini del genere. Senonché noi, al principio, abbiamo già rilevato che il fatto stesso dell’ininterrotto, impenetrabile travestirsi della dottrina ermetica in un periodo in cui parlar di palingenesi in quel senso «mistico» non costituiva una eresia, indica che in realtà si trattava di cosa diversa: di cosa, per la quale si imponeva quella legge del silenzio, che già era stata rigorosamente osservata dai Misteri pagani.
Aver indicato la derivazione della tradizione ermetica da una vena «regale» e «eroica» di quella primordiale è, sì, un punto per comprendere l’occultamento nel periodo del cristianesimo dominante. Ma esso non è il solo. Ve ne è un altro, cui si potrebbe riferire la massima, che «il Saggio con la sua sapienza non deve turbare la mente di coloro che non sanno»: massima, che doveva valere in modo tanto più rigoroso in un periodo in cui il numero di «coloro che non sanno» era quasi divenuto quello della totalità.
Per spiegarci, occorre rifarsi ad un insegnamento tradizionale fondamentale, del resto già accennato: a quello concernente le due nature.
Vi è la natura degli immortali e vi è la natura dei mortali; vi è la regione superiore di «coloro-che-sono» e vi è la regione inferiore del «divenire». L’idea, che i due rami in origine possano esser stati una sola cosa — come secondo il detto esiodeo, che «una è la schiatta degli uomini, una quella degli Dei, entrambe scaturite da una stessa madre» — e che la dualità sia sorta da un precipitar degli uni, da un ascender degli altri — come secondo la concezione ermetico-eraclitea del dio quale «uomo immortale» e dell’uomo quale «dio mortale» — una tale idea non escludeva che la differenziazione esistesse di fatto, e che due fossero dunque le nature.
 Il passaggio dall’una all’altra era considerato possibile — ma a titolo eccezionale e sotto la condizione di una trasformazione essenziale effettiva, positiva, da un modo di essere ad un altro modo di essere. Siffatta trasformazione era conseguita a mezzo dell’iniziazione nel senso più stretto del termine. Attraverso l’iniziazione alcuni uomini sfuggivano all’una natura e conquistavano l’altra, cessando così di essere uomini. Il loro apparire nell’altra forma di esistenza costituiva, nell’ordine di quest’ultima, un avvenimento rigorosamente equivalente a quello della generazione e della nascita fisica. Essi dunque ri-nascevano, erano ri-generati. Come la nascita fisica implica la perdita della coscienza dello stato superiore, cosi la morte implica quella della coscienza dello stato inferiore. Pertanto, nella misura in cui si è perduta ogni coscienza dello stato superiore — cioè, nei termini a noi ormai noti, nella misura in cui è avvenuta l’«identificazione» (l’immedesimazione) — in quella stessa misura la perdita della coscienza dello stato inferiore (quella umana), provocata dalla morte e dal disfarsi del sostegno di tale coscienza (il corpo), equivarrà alla perdita di ogni coscienza in senso personale. Al sonno eterno, all’esistenza larvale nell’Ade, alla dissoluzione pensata come destino di tutti coloro per i quali le forme di questa vita umana costituirono il principio e la fine — non scamperebbero dunque che quelli che già in vita abbiano saputo orientare la loro coscienza verso il mondo superiore. Gli Iniziati, gli Adepti stanno al limite di tale via. Conseguito il «ricordo», l’anamnesis, secondo le espressioni di Plutarco essi divengono liberi, vanno senza vincoli, coronati celebrano i «misteri» e vedono sulla terra la folla di coloro che non sono iniziati e che non sono «puri», schiacciarsi e spingersi nel fango e nelle tenebre (1).
Il passaggio dall’una all’altra era considerato possibile — ma a titolo eccezionale e sotto la condizione di una trasformazione essenziale effettiva, positiva, da un modo di essere ad un altro modo di essere. Siffatta trasformazione era conseguita a mezzo dell’iniziazione nel senso più stretto del termine. Attraverso l’iniziazione alcuni uomini sfuggivano all’una natura e conquistavano l’altra, cessando così di essere uomini. Il loro apparire nell’altra forma di esistenza costituiva, nell’ordine di quest’ultima, un avvenimento rigorosamente equivalente a quello della generazione e della nascita fisica. Essi dunque ri-nascevano, erano ri-generati. Come la nascita fisica implica la perdita della coscienza dello stato superiore, cosi la morte implica quella della coscienza dello stato inferiore. Pertanto, nella misura in cui si è perduta ogni coscienza dello stato superiore — cioè, nei termini a noi ormai noti, nella misura in cui è avvenuta l’«identificazione» (l’immedesimazione) — in quella stessa misura la perdita della coscienza dello stato inferiore (quella umana), provocata dalla morte e dal disfarsi del sostegno di tale coscienza (il corpo), equivarrà alla perdita di ogni coscienza in senso personale. Al sonno eterno, all’esistenza larvale nell’Ade, alla dissoluzione pensata come destino di tutti coloro per i quali le forme di questa vita umana costituirono il principio e la fine — non scamperebbero dunque che quelli che già in vita abbiano saputo orientare la loro coscienza verso il mondo superiore. Gli Iniziati, gli Adepti stanno al limite di tale via. Conseguito il «ricordo», l’anamnesis, secondo le espressioni di Plutarco essi divengono liberi, vanno senza vincoli, coronati celebrano i «misteri» e vedono sulla terra la folla di coloro che non sono iniziati e che non sono «puri», schiacciarsi e spingersi nel fango e nelle tenebre (1).
A dir vero, l’insegnamento tradizionale circa il post-mortem ha sempre sottolineato la differenza esistente fra sopravvivenza ed immortalità. Possono esser concepite varie modalità, più o meno contingenti, di sopravvivenza per questo o quel principio o complesso dell’essere umano. Ma ciò non ha a che fare con l’immortalità, la quale può essere solo pensata come «immortalità olimpica», come un «divenir dèi». Tale concezione permase in Occidente fino all’antichità ellenica. Dalla dottrina appunto delle «due nature» procedeva la conoscenza del destino di una morte, o di una precaria, larvale sopravvivenza per gli uni, di una immortalità condizionata (condizionata dall’iniziazione) per gli altri. Fu la volgarizzazione e l’abusiva generalizzazione della verità valida esclusivamente per gli iniziati — volgarizzazione che prese inizio in alcune forme degeneri dell’orfismo ed ebbe poi ampio sviluppo col cristianesimo — a dar nascita alla strana idea dell’«immortalità dell’anima», estesa a qualsiasi anima e sottratta ad ogni condizione. Da allora sino ad oggi, l’illusione continua nelle varie forme del pensiero religioso e «spiritualistico»: l’anima di un mortale è immortale — l’immortalità è una certezza, non una possibilità problematica (2).
Stabilito cosi l’equivoco, pervertita in tal senso la verità, l’iniziazione non poteva più apparire necessaria: il suo valore di operazione reale ed effettiva non poteva più esser compreso. Ogni possibilità veramente trascendente fu a poco a poco obliata. E quando si continuò a parlar di «rinascita», il tutto di massima si esaurì in un fatto di sentimento, in un significato morale e religioso, in uno stato più o meno indeterminato e «mistico». Far capire, in secoli dominati da questo errore, che qualcosa d’altro è possibile; che ciò che gli uni tenevano per un sicuro possesso e gli altri per una gratuita speranza è un privilegio, legato ad un’Arte segreta e sacra; far capire che, come nel mondo dei determinismi della materia e dell’energia, così pure nelle operazioni di quest’Arte la morale, la fede, la devozione e il resto sono elementi inefficaci rispetto alla caducità umana [«agli dèi bisogna farsi simili, non già agli uomini da bene: non l’esser esenti dal peccato, ma l’essere un dio «è il fine» — aveva già detto Plotino (3)]; dichiarar dunque la relatività di tutto ciò che è religione, speculazione e morale umana per additare il punto di vista della realtà nella sua trascendenza rispetto ad ogni costruzione mortale (4); parlar di Dio come di un simbolo per l’altro stato di coscienza; dell’attesa del Messia come della melior spes nutrita da chi tentava l’iniziazione; della «resurrezione della carne» come di un altro simbolo per una rigenerazione nei principi stessi dell’organismo, la quale può compiersi già in vita — darsi a tentativi di questo genere, sarebbe stato ormai vano. E come sarebbe stato possibile evitare il più triste degli equivoci usando le stesse parole, gli stessi simboli primordiali? Molto meglio parlar dunque di Mercurio e di Solfo, di metalli, di cose sconcertanti e di operazioni impossibili, ottime per attrarre l’avidità e la curiosità di quei «soffiatori» e di quei «bruciatori di carbone» dai quali doveva nascere la chimica moderna, e per non lasciar sospettare agli altri, nelle rare ed enigmatiche allusioni, che si trattasse, nell’essenza, di un simbolismo metallurgico per cose dello spirito, per far credere invece (come ancor oggi gli spiriti positivi che fanno la storia della scienza lo credono) che si trattasse di un allegorismo mistico per cose metallurgiche e per opere di una scienza da dirsi naturale e profana di fronte al dominio sovrannaturale della fede e del dogma.
Per conto nostro, su tale base giungiamo a comprendere l’opportunità dell’occultamento, anzi sino al punto di deplorare che esso non sia poi stato tale, da render impossibili, al giorno d’oggi, certe interpretazioni «spiritualistiche» dell’alchimia, le quali, non sottraendola all’incomprensione inoffensiva degli storici della scienza che per portarla sul piano mistico-moralistico e persino psicanalitico (5), fanno davvero peggio di chi non togliesse dalla padella che per gittar nella brace.
Invece è colui che sia stato portato positivisticamente a ritenere che ogni facoltà psichica e spirituale è condizionata e determinata da fattori empirici (organici, di eredità, d’ambiente, ecc.) e che dal nichilismo nietzschiano sia stato condotto al senso della relatività di tutti i valori e alla grande rinuncia, alla «rinuncia a credere» — è forse una tale persona quella che oggi si trova nella disposizione più favorevole per poter comprendere l’effettiva portata del compito ermetico e iniziatico.
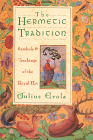 Qui la «rinascita» non è dunque un sentimento o una allegoria, ma un fatto preciso, che non può esser compreso da chi non sia passato attraverso il Mistero. Il suo senso vero, se mai — come lo nota giustamente il Macchioro — lo si può adombrare abbandonando le concezioni spiritualistico-religiose e venendo a quanto è ancora presente, al titolo di residui degenerescenti di un insegnamento superiore primordiale, nei popoli primitivi. «In essi — scrive il Macchioro — la palingenesi non «è allegoria, ma realtà, ed è tanto reale, che spesso essa è ritenuta fatto fisico e materiale. Il Mistero non ha lo scopo di insegnare, ma rinnova l’individuo. Non vi è nessuna ragione che giustifichi od imponga questo rinnovamento: la palingenesi occorre, ecco tutto» (7). E come se le condizioni necessarie per il prodursi di un fenomeno fisico sono presenti, questo fenomeno avviene in modo certo; cosi pure se le condizioni necessarie per il prodursi dell’iniziazione sono presenti, la rinascita avviene, in modo altrettanto certo e altrettanto indipendente da ogni merito. È cosi che ad Eleusi si poteva coerentemente sostenere che un bandito, se iniziato, partecipa all’immortalità, mentre un Agesilao e un Epaminonda, se non iniziati, non avrebbero avuto dopo la morte un destino migliore di quello di un qualsiasi altro mortale. Se già a quel tempo un Diogene poteva trar scandalo da siffatta veduta, oggi naturalmente saranno assai di più coloro che possono imitarlo. Chi invece, avendo abbandonato la concezione irrealistica circa ciò che non è corporale, si sia fatto capace di considerare anche lo spirito come una forza oggettiva — forza agente, reagente, necessitante, determinata e determinante — non troverà la cosa più contro natura, di quel che non sia il fatto, che se un bandito, Epaminonda e Agesilao fossero oggi messi in contatto con un circuito ad alta tensione, la corrente non risparmierebbe di certo Epaminonda e Agesilao per la loro «virtù», fulminando invece il bandito per le sue colpe.
Qui la «rinascita» non è dunque un sentimento o una allegoria, ma un fatto preciso, che non può esser compreso da chi non sia passato attraverso il Mistero. Il suo senso vero, se mai — come lo nota giustamente il Macchioro — lo si può adombrare abbandonando le concezioni spiritualistico-religiose e venendo a quanto è ancora presente, al titolo di residui degenerescenti di un insegnamento superiore primordiale, nei popoli primitivi. «In essi — scrive il Macchioro — la palingenesi non «è allegoria, ma realtà, ed è tanto reale, che spesso essa è ritenuta fatto fisico e materiale. Il Mistero non ha lo scopo di insegnare, ma rinnova l’individuo. Non vi è nessuna ragione che giustifichi od imponga questo rinnovamento: la palingenesi occorre, ecco tutto» (7). E come se le condizioni necessarie per il prodursi di un fenomeno fisico sono presenti, questo fenomeno avviene in modo certo; cosi pure se le condizioni necessarie per il prodursi dell’iniziazione sono presenti, la rinascita avviene, in modo altrettanto certo e altrettanto indipendente da ogni merito. È cosi che ad Eleusi si poteva coerentemente sostenere che un bandito, se iniziato, partecipa all’immortalità, mentre un Agesilao e un Epaminonda, se non iniziati, non avrebbero avuto dopo la morte un destino migliore di quello di un qualsiasi altro mortale. Se già a quel tempo un Diogene poteva trar scandalo da siffatta veduta, oggi naturalmente saranno assai di più coloro che possono imitarlo. Chi invece, avendo abbandonato la concezione irrealistica circa ciò che non è corporale, si sia fatto capace di considerare anche lo spirito come una forza oggettiva — forza agente, reagente, necessitante, determinata e determinante — non troverà la cosa più contro natura, di quel che non sia il fatto, che se un bandito, Epaminonda e Agesilao fossero oggi messi in contatto con un circuito ad alta tensione, la corrente non risparmierebbe di certo Epaminonda e Agesilao per la loro «virtù», fulminando invece il bandito per le sue colpe.
È proprio dunque all’Arte ermetica, come ad ogni altra forma di metodo iniziatico, orientale o occidentale, distaccar l’individuo dai valori «umani» per porgli invece il problema dello spirito in termini di realtà. Ma l’individuo si trova allora di fronte al proprio corpo, nodo fondamentale di tutte le condizioni del suo stato. La considerazione del rapporto fra il principio-io, nella doppia forma di conoscenza e di azione, e la corporeità (del senso completo di questo termine), e la trasformazione di siffatto rapporto a mezzo di operazioni o atti ben determinati, efficaci e necessitanti, per quanto essenzialmente interiori, costituisce l’essenza dell’Arte Regia dei Maestri ermetici. La quale si intenderà per primo a conquistare il principio dell’immortalità, poi a trasporre nella natura stabile, non più caduca, gli elementi e le funzioni su cui si basava l’apparizione umana nella regione del divenire. Flamel dice: «La nostra Opera è la conversione e il cangiamento di un essere in un altro essere, come di una cosa in un’altra cosa, della debolezza in forza… della corporeità in spiritualità» (8). Ed Ermete: «Converti e cambia le nature, e troverai ciò che cerchi» (9).
Note
1 In Stobeo, Flor., IV, 107. Secondo il Corpus Hermeticum (XXII, 3) l’uomo ha la speranza dell’immortalità; è detto che non tutte le anime umane sono immortali, ma solo quelle che divengono dei «dèmoni» (X, 7, 19). Ciò che decide, è il loro grado di identificazione ad essi. Pitagora avrebbe ammesso che «l’anima in certi casi può divenire mortale, quando si lascia dominare dalle Erinni, cioè dalle passioni, e ridivenire immortale una volta sfuggita alle Erinni, che son sempre le passioni» (apud Ippolito, Philos., VI, 26).
2 Circa il cristianesimo, nelle origini esso presentò un aspetto di dottrina tragica della salvazione che in una certa misura conserva l’eco dell’antica verità: è l’idea — esasperatasi poi con Lutero e Calvino — che l’uomo terreno si trova al bivio fra etema salvazione e eterna perdizione.
3 Enneadi, I, ii, 7; I, ii, 6.
4 Nei riguardi delle discipline profane così si esprime un testo alchemico arabo: «Chi conosce questa [nostra] Scienza, per poco che sia, meritando di essere uno dei suoi adepti, è superiore agli spiriti che più si sono distinti in tutte le altre scienze. Infatti ogni uomo istruito in una scienza qualunque, e che non ha consacrato una parte del suo tempo allo studio di uno dei principi dell’Opera, in teoria o in pratica, possiede una cultura intellettuale assolutamente inferiore. Tutto ciò che può fare è allinear parole, combinar frasi o concrezioni della sua imaginazione, e ricercar cose che non hanno esistenza propria, e che tuttavia egli crede esistere al di fuori di lui» (Trattato sul Mercurio Occidentale, CMA, III, 214). Lo stesso Aristotele, sebbene considerato come «il più brillante degli esseri non luminosi», non avrebbe nulla a che fare con gli esseri che hanno conseguito lo stato incorporeo (CMA, Testi siriaci, II, 264). E nel Corp. Herm., XVI, 2: «I Greci, o Rè, hannoforme nuove di linguaggio per produrre delle prove e la loro filosofia è un rumore di parole. Noi invece non usiamo parole, ma la gran voce «delle cose».
5 È quel che ha fatto in modo sistematico lo psicanalista C.G. Jung nella sua opera Psicologia e Alchimia, a base di « inconscio » di «proiezioni dell’inconscio», e simili.
6 V. Macchioro, Eraclito, Bari, 1922, pp. 119-120.
7 Ibid.
8 N. Flamel, Dés. désiré.
9 Ibid.
Il presente scritto costituisce l’introduzione alla Parte Seconda del libro di Julius Evola La tradizione ermetica nei suoi simboli, nella sua dottrina e nella sua “Arte regia”, Edizioni Mediterranee(4), Roma 1996.
Tratto dalla newsletter “BFT” – http://groups.yahoo.com/group/Bollettino_FT
Lascia un commento